Cammino Lauretano




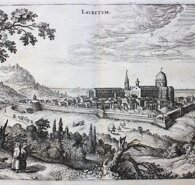

SVOLGIMENTO DEI PELLEGRINAGGI
Nella descrizione dei suddetti quattro gruppi ricorrono solo alcune componenti e tipologie peregrinatorie comuni ad altre comitive di diversa provenienza.
I pellegrini in gruppo
È stato opportunamente notato che, almeno fin dal secolo XV, il pellegrinaggio lauretano si caratterizzava come " mariano e sacramentale-penitenziale ".
Nel secolo XV è restato famoso il pellegrinaggio compiuto a Loreto nel 1458 da Roberto Sanseverino e dai suoi compagni, di ritorno dalla terra Santa, dopo che una violenta tempesta gli aveva sbattuti ad Ancona. Durante la tempesta la maggior parte, "etiam in spetiale se votarono ad andare" a "Nostra Signora di Loreto", "chi ad cavallo, chi ad piede, chi battendosi, chi con corde al collo, chi in un modo, chi in un altro".
Luca da Monte rado sottolinea: " probabilmente questa doveva essere la forma comune del pellegrinaggio penitenziale, almeno nelle ultime tappe di viaggio".
È però nel secolo XVI che si cominciano ad avere descrizioni dettagliate sul modo di pellegrinare da parte di gruppi diversi.
Orazio Torsellini, già nel 1597, dopo aver annotato che i gruppi provenivano soprattutto dai " popoli confinanti dell'Abruzzo, dell'Umbria, della Romagna e del restante d' Italia", avvertiva:"il modo di andare è pressoché identico ". ed era questo: precedevano le confraternite, distinte sotto i loro propri stendardi, recando quasi tutte, oltre ai crocifissi, immagini della Madonna e di altri santi; Seguivano i priori delle stesse e i sacerdoti, con le musiche di ciascun gruppo; infine, dietro, venivano portati i doni, come corone d'argento, calici, cassette per danari, vesti preziose, ritratti in argento di città e paesi, tavolette ex voto, segni vari di protezione ottenuta per intercessione della Vergine Lauretana, ecc.
Esistevano, però, delle varianti a questo modo di pellegrinare. Lo osservava lo stesso Torsellini, quando scriveva che spesso si raccoglieva insieme un confuso e disordinato miscuglio di persone. Le quali, transitando di luogo in luogo, cantavano per via le lodi a Dio, alla Vergine e ai santi, suscitando presso la gente, al loro passaggio, viva devozione alla Madonna di Loreto.
Il Torsellini aggiunse che i pellegrini delle regioni limitrofe, appena sporgevano da lontano il santuario di Loreto, visibile sul verde colle, tutti insieme si inginocchiavano e, piangendo di gioia, salutavano la Madonna. Quindi, disposti in ordinato corteo, si dirigevano verso il santuario, cantando le Litanie Lauretane e inni vari. Alcuni, tolte le vesti da viaggio, indossavano un sacco penitenziale e si flagellavano le spalle. Questo loro gesto penitenziale ci fa venire in mente l'immensa moltitudine di penitenti, di cui parla il Riviera, i quali, intorno alle 13 39, inviluppati nei loro lunghi sacchi bianchi, si sarebbero riversati al santuario Loredano, invitando alla conversione e alla pace gli animi inviperiti da odi fratricidi.
Sempre secondo il Torsellini, i sacerdoti del santuario, in cotta, andavano incontro ai pellegrini all'antica porta di Loreto e gli accompagnavano in chiesa con musiche, al suono di trombe e al concerto di campane a festa.
Davanti la S. Casa i pellegrini si inginocchiavano di nuovo in atto di venerazione verso la vergine, in atteggiamenti e in espressioni che toccavano gli anni degli astanti. Quindi entravano nel sacello manifestando con gesti e con preghiere la loro fervida devozione verso la S. casa.
Questo modo di pellegrinare dovette durare per lungo tempo. Se ne ha una riprova in un commento alle Litanie Lauretana me, pubblicato nel 1748 dal frate conventuale Domenico serafini, il quale, dopo aver osservato che i pellegrini a Loreto avevano un comportamento più devoto che non Roma, annotava:
"Mentre per la via procurano andare tutti raccolti e dimessi, recitando continue lodi alla Gran Madre di Dio, arrivati appena a scoprire le mura che racchiudono quell'inestimabile Tesoro, eccitati internamente da straordinaria devozione, gettandosi a terra e prorompendo dirottissimi pianti, incominciano a salutar Maria Santissima. E qui alcuni deponendo le loro vestimenta si ricoprono di bronzo sacco, altri con fiere discipline percuotono anzi le spalle, e altri richiamandosi a sè procuran con tanta modestia e devozione terminare i loro viaggio. Giunti appena alla porta del tempio, si prostrarono nuovamente a terra e con nuovi fervori salutano la nostra Corredentrice. Entrati perciò nella Santa casa, quali siano i loro affetti, quali le loro espressioni in far nota a Maria la sincerità del loro cuore, non è a me facile spiegarlo."
Un cenno a parte merita il pellegrinaggio organizzato dalla compagnia di San Benedetto Bianco di Firenze. Essa accompagnò Pellegrini al Loreto più volte. La documentazione segnala gli anni 1602,1651,1676,1677 e 1715.
Nel 1676 vi partecipò anche il noto poeta Vincenzo affilata taglia, il quale lasciò in merito un manoscritto, edito nel 1821.
L'autore divide il pellegrinaggio in ventuno "giornate ", descrivendo con vivaci particolari il itinerario nei suoi vari momenti di svago e di preghiera.
il gruppo comprendeva circa 60 persone, tutte di spicco o percento o per cultura. Dai partecipanti venivano designati tre consiglieri, quattro capi, due sagrestani e un cerimoniere. Ognuno doveva versare la somma di 16 scudi e un contributo libero per il dono da farsi al santuario di Loreto. Inoltre, ciascuno si provvedeva del necessario per il viaggio, compreso il cavallo e il servitore, e di una speciale veste talare di robusto tessuto. La compagnia forniva il Bordone e una veste corta da viaggio.
I pellegrini procedevano ora piedi, ora a cavallo, cantando frequentemente inni sacri. Nelle città talora venivano accolti dalle stesse autorità e spesso gli amici offrivano loro lauti banchetti.
A Recanati si disponevano processionalmente verso Loreto, cantando il Benedictus e il Te Deum. All'apparire della cupola del santuario si inginocchiavano e intonavano il canto della prima strofa dell'Ave Maris Stella. Prima di entrare in basilica mutavano levereste corta con quella talare e un'altra bianca. Quindi, al canto delle li cani Lauretana, facevano il solenne ingresso, portandosi all'altare del sacramento per l'adorazione. Solo il giorno successivo, dopo la confessione e la comunione, entravano in Santa casa, mentre prima si limitavano a cantare dall'esterno Ave gratie.
Esisteva, dunque, una certa varietà in materia. Il citato Torsellini, dopo la surriferita descrizione, informava che, se questo era "pressoché in modo dell'ordine" di pellegrinare dei "popoli confinanti", alquanto diverso era quello dei "pellegrini di paesi lontani".
Alcuni di questi giungevano confusamente a piedi, altri a cavallo o in carrozza, distinguendosi per i peculiari costumi. Annota però che, pur nella diversità delle abitudini, tutti i pellegrini avevano in comune la riverenza e devozione verso la Santa casa, e tutti si confessavano e comunicavano lasciando poi svariati doni al santuario, in danaro e il oggetti preziosi.
Anche le truppe di fanteria e cavalleria pellegrinare anno al Loreto sempre a detta del tortellini, in qualunque periodo dell'anno. I soldati giungevano al santuario a piedi e si accostavano devotamente al sacramento della confessione. Essi, poi, usavano onorare la vergine Lauretana "con finte scaramucce" , cioé con scene guerresche.
Guide e itinerari
Oltre che a gruppi organizzati o spontanei, il pellegrinaggio loretano si svolgeva anche isolatamente o in minuscole comitive formate da membri di singole famiglie, dal personale al seguito di qualche principe,signore,cardinale,ecc.
Già fin dal secolo XV il santuario di Loreto era inserito nei noti Mirabilia Urbis Romae. In un'edizione del 1492 è riprodotta una canzone in lingua italiana di soggetto loretano e in altre due edizioni del 1524 è inserita la relazione del Teramano. Il fatto attesta, fra l'altro, il collegamento tra Roma e Loreto in un unico percorso peregrinatorio.
Fin dal secolo XV e per tutto il secolo XVI i pellegrini loretani cantavano anche canzoni religiose in lingua italiana, scritte per lo più in ottava rima, intonate a uno spirito essenzialmente penitenziale. Le "canzoni" avevano in genere questo titolo "La oratione de S.Maria de Loreto".
Per i pellegrini isolati o raccolti in minuscoli gruppi - ma non solo per loro - esistevano delle Guide, scritte talvolta da chi, in base alla propria esperienza, intendeva facilitare l'itinerario di altri romei.
Il veneziano Bartolomeo Fontana, ad esempio, pellegrino nel 1538 a Loreto, Assisi,Roma e S.Giacomo Di Compostela, compilò un Itinerario proprio a tale scopo. Egli, nelle pagine iniziali, avverte:
"Considerando tra me medesimo quanto sia laudabile cosa giovare altrui e maggiormente alli poveri romieri che vanno, e per lo più delle volte non sanno dove, per essere incauti delli passi delle terre, onde molte volte allungano il cammino o lo fallano e smarriti vagando restano poi alla coperta del cielo sulle campagne, mi sono perciò a universale utilitá di peregrini deliberato a comporre il presente itinerario".
La prima avvertenza che il Fontana rivolge ai romei è la seguente:
"Che sia a memoria che la prima cosa che fanno la mattina in viaggio sia d'orare et raccomandarsi al Signore".
Nel secolo XVI fu ristampata per ben tre volte (nel 1575,1576 e in un altro anno non noto) la Istruttione de peregrini che vanno alla Madonna di Loreto, scritta da p.Luigi da Granata. Il sottotitolo esplicita la materia: " ove si tratta della confessione et comunione et ivi si pongono rimedij generali contra il peccato mortale".
Esistevano anche Guide o Itinerari o Regolamenti per i pellegrinaggi organizzati che vedevano la partecipazione di molti devoti. Alcuni di questi vademecum erano più attenti alle esigenze logistiche, con l'indicazione di cittá,di strade, di distanze,di accorciatoie,di spizi, di locande, ecc;altri avevano un carattere più religioso e tendevano all'organizzazione del pellegrinaggio in quanto tale, con il suggerimento di preghiere e di riti, secondo una precisa tabella di marcia.
È noto in proposito il Viaggio alla S.Casa, redatto nel 1612 da p.Cesare Franciotti, chierico regolare della Madre di Dio, il quale descrive un pellegrinaggio distribuito in dodici giornate, con precisi consigli sull'ordine e sul metodo da seguire.
In Francia era molto noto lo spesso volume di 640 pagine di Louis Richeome, gesuita, intitolato Le pèlerin de Lorette, pubblicato nel 1604, il quale, secondo il Colliard, sarebbe stato utilizzato anche da Renè Descartes , recatosi a loreto nel 1624 per sciogliere un famoso voto.
Anche gli addetti al santuario loretano si premuravano di preparare "guide spirituali" o utilizzarne di quelle presenti di altri luoghi. Il Martorelli nel 1735 pubblicò uno scritto dal titolo: Quello che deve fare ogni pellegrino, o vero persona, che per sua devozione va a visitare la Madonna di Loreto e altri luoghi santi.
In trentuno brevi paragrafi vengono offerti suggerimenti sul comportamento esterno e sull'atteggiamento interiore da mantenere lungo l'itinerario e nel santuario.
Lo stesso autore pubblicò una Istruzione pratica per visitare devotamente la S.Casa di Loreto con un buon metodo per fare speditamente la confessione generale.
L'istruzione accompagna il pellegrino in cinque visite alla S.Casa, con riflessioni sulla concezione immacolata di Maria, sulla sua nascita,sul mistero dell'incarnazione,tutti eventi compiutesi nella S.Casa, sulla vita di Gesù,Maria e Giuseppe svoltasi nella stessa dimora nazaretana, e sulla presenza degli apostoli nel medesimo luogo.
L'Istruzione è arricchita di preghiere intonate alla S.Casa e di schemi per la fruttuosa confessione.
Afflusso di peregrini: periodo e numero
Un documento del 1315, che segnala un furto operato nel 1313 da alcuni recanatese ai danni del santuario di Loreto, fa intendere che l'afflusso maggiore vi si registrava, già alle origini, nei mesi di agosto, settembre, febbraio e marzo, rispettivamente nelle feste della Assunta (15 agosto), della Natività di Maria 8 settembre, della purificazione della madonna 2 febbraio e dell'annunciazione (25 marzo). Se ne ha una conferma in un breve di Gregorio XI del 2 novembre 1375, nel quale si legge che una moltitudine di fedeli affluiva al Santuario, mossa da devozione, nelle feste dell'annunciazione, della purificazione e della Natività di Maria.
Il Torsellini, nel 1597, annotava che il concorso più intenso dei pellegrini si verificava intorno alle feste di Pasqua, di Pentecoste e della Natività della Vergine.
Per la festa di Pasqua, ai numerosi pellegrini della regione marchigiana si aggiungevano quelli provenienti dalla Lombardia, dalla Repubblica veneta e dalla Dalmazia, questi ultimi numerosissimi.
Ancor maggiore era l'afflusso per la vigilia e per la festa Mariana dell'8 settembre, giacché-scrive il Torsellini- " concorreva al Loreto poco meno che tutto il Piceno, senza dire delle altre province ". E sottolinea: " costa chiaramente che in quei due giorni, poco tempo fa, oltre 200.000 persone si siano recate alla Santa casa ".
Anche per la festa dell'annunciazione, la più intimamente legata alla Santa casa, gli storici segnalano un grande concorso di Pellegrini. Nel 1560 ne sarebbero giunti 40.000.
Si legge anche che Sisto V, nelle 1586, benedisse 80.000 corone del rosario da distribuire al Loreto e che esse non furono sufficienti alle richieste.
L'eccezionale afflusso continuò nei secoli successivi. Il serraglio nel 16 35 assicurava che ordinatamente da Pasqua Pentecoste il numero dei pellegrini si aggirava tra le cinque e le 600.000 unità, cifre astronomiche per quei tempi. Lo stesso descrive ampiamente lo straordinario concorso di folle a Loreto.
Nel 17 84 il Gaudenti informa che, ai suoi tempi, ogni anno gli illirici raggiungevano le tre-quattrocento unità, come i fiamminghi, i spagnoli e i polacchi, mentre i francesi toccavano le 2000 unità e i tedeschi le 5000. La gran massa dei pellegrini ovviamente proveniva dall'Italia. Il Gaudenti precisa che nelle settembre 1780 volle controllare di persona il numero delle ostie preparate dai cappuccini e distribuite ai fedeli: furono 63.000!.
Per chi ama il affronti, si può assicurare nel settembre 1989 sono state distribuite nel santuario 67.000 comunioni, cifra di poco superiore a quella registrata nel1780. Ma è anche da dire che oggi la presenza dei pellegrini al Loreto viene registrata lungo tutto l'arco dell'anno. Nel 1988 furono distribuite 660.000 comunioni.
queste rapide spigolature danno l'idea dello straordinario flusso per peregrinatorio a Loreto nei secoli passati, distribuito con ritmi periodici costanti e ben definiti.
Per quel che concerne i paesi di provenienza dei pellegrini, almeno per la seconda metà del cinquecento, sono emblematici alcuni versi di Torquato Tasso, il quale, come è noto, scrisse una celebre canzone ha la beatissima vergine di Loreto in seguito a un suo pellegrinaggio al santuario di Loreto nel 1587. Nella VII strofa il poeta scrive:
E tragge a rimirar l santa imago
Da l'estremo occidente a stuolo a stuolo,
Peregrinando con tranquilla oliva,
Quei che dinanzi bevevan l'Ibero e il Tago,
E dà regni soggetti al freddo polo
Di lá da l'Istro e di più algente riva;
E mille voti alla Celeste Diva,
Che scaccia i nostri mali,
Solvon gli egri mortali,
Il cui pregar al ciel per grazia arriva [...].
Anche Lorenzo Frizolio, in un'ode latina, scritta nel 1578 mette in evidenza nella IV strofa la diversa e lontana provenienza dei pellegrini Loretani:
Vengono a visitare te, santa dei potenti,
Le pie torme degli italiani,
Te visitano in folla l'abitante del Rodano,
Colui che beve il Tago, i Liburnia, gli Armeni.
GESTI DEVOZIONALI E TRADIZIONI
Si possono indicare i seguenti momenti e gesti o " devozioni ", frequenti nei pellegrini Loretani dei tempi passati.
Le abluzioni alle fontane
I pellegrini giungevano al Loreto da tre diverse direzioni: da nord, per la via che da Ancona, attraverso Camerano e San rocchetto, conduceva a villa musone e, lungo la " costa di Ancona ", al santuario; oppure Si giungeva attraverso Sirolo, Montorsoli, le casette; dal sud, sulla via che da Monte Santo-oggi Potenza Picena-, lungo la contrada del Carpine e la discesa di Montereale, portava in piazza della madonna; oppure vi si poteva arrivare dalla strada marina, lungo porto Recanati e le casette; da ovest, con frequente provenienza da Roma e da Assisi, vi si arrivava attraverso Recanati, in tempi più remoti per la via dell'impaccio, successivamente Per la Valle cerro e, dalla fine del secolo 16º, attraverso il tracciato attuale.
Uno dei primi gesti del pellegrino, oscillante tra l'esigenza igienica e la devozione, era quello delle abluzioni nelle fontane vicino al santuario.
Una prima detersione, volta a eliminare il fango, la polvere e il sudiciume, aveva luogo alle fontane periferiche, e cioè: alla " fonte della croce ", sulla costa di Ancona, per quelli che provenivano dal nord; alla " fonte della Buffolareccia " per quelli provenienti da nord, lungo Montorso, E da sud, lungo la strada marina; alla " fonte del Carpine " per quelli che, da sud, giungevano da Monte Santo o, da ovest, da Recanati.
Il percorso da Monte Santo a Loreto era detto un tempo " via dei credo ", perché i pellegrini, prima di raggiungere la " fonte del Carpine ", dovevano recitare 33 credo e, dopo la detersione, recitavano o cantavano le litanie Lauretane.
Anche la " fontanella delle scalette " e la " fontana dei galli ", situate nel centro urbano, erano usate talvolta allo stesso scopo.
Nella fontana della madonna, nella piazza del santuario, i pellegrini spesso ripetevano le abluzioni, che qui potevano anche assumere il significato di un rito, fatte com'erano nell'intento di una detersione fisica che diventava segno di una purificazione spirituale.
Lo notava implicitamente il ferrante per i ciociari, quando scriveva che essi, nella fontana della madonna, si lavavano i piedi per poter entrare, così detersi e scalzi, nel Santuario.
Ingresso in basilica
Già nelle 1559, come testimonia il Riviera, i pellegrini illirici entravano in basilica ginocchioni, imitati successivamente da altri gruppi. L'uso era ancora diffuso nel secolo XIX-XX, come si è rilevato per i ciociari, i regnicoli e i "cecchi".
Esistono stampe e incisioni raffiguranti i pellegrini che procedono in ginocchio dalla fontana della madonna, lungo il restante tratto della piazza e sulle gradinate della basilica, verso l'interno della stessa. Una delle più antiche incisioni del genere, risalente al secolo XVIII, fu eseguita da Ch.Calaisse su disegno di Ch.De Vase (mm 120X190).
Altri due disegni che illustrano questo rito sono stati pubblicati dal Carrata nel 1893. Il gesto stava a indicare il sommo rispetto per la santità del luogo, che conserva la casa nazeratana della Madonna: un lembo di terra santa sul suolo di Loreto.
Lo stesso sentimento di riverenza spingeva i ciociari a entrare scalzi nel tempio dell'incarnazione. Vengono in mente le parole che si leggono in esodo, 3,5, rivolte da Dio a Mosé: " togliti i sandali dai piedi, perché il luogo dove tu stai Terrasanta! ".
Non sempre però lo stuolo dei Pellegrini faceva l'ingresso in basilica ginocchioni o carponi. Spesso dalla piazza della Madonna procedeva lentamente e ordinatamente con gli stendardi delle antiche confraternite sollevati e spiegati.
Il giro in ginocchio attorno alla Santa casa
È forse il gesto più caratteristico dei pellegrini al santuario di Loreto, sembra che la prima notizia risalga all'indomani della messa in opera del rivestimento marmoreo ( 15 34 ), secondo una nota d'archivio relativa al confessori. Vi si dice che il penitenziere Como comunichista ogni sabato era tenuto a fare un giro intorno alla Santa casa insieme al fedeli e al Pellegrini, recitando le litanie, dettando una breve riflessione e, infine, impartendo la benedizione con la croce.
Da allora sfogliasti Pellegrini, fino ai giorni nostri, hanno ripetuto il pio esercizio che aveva e ha carattere penitenziale.
Anche altri personaggi si sono umiliati a fare un gesto del genere. Il gesuita P. Luc Antonio forti, in un manoscritto irreperibile, citato dal Martorelli, riferisce che Maria Casimira, regina di Polonia, pellegrina a Loreto nel 1698 deposte le vestito regali, " non arrossì " di fare un giro intorno al sacello con le ginocchia.
Non sono mancati però nel passato critiche e accenti ironici verso questa pia pratica. Il Martorelli cita, in proposito, il Misson, " che si burlava di quella compagnia de pellegrini che ginocchioni giravano intorno alla Santa cappella trotterellando ( come per ischerno ei scrisse) sopra le loro ginocchia ".
Nel passato, come ancora oggi, i pellegrini, nel fare quella disagevole percorso con le ginocchia, recitavano anche il rosario. Lo aveva notato già Johan Gaspar Goethe -Il padre del celebre Wolfang, autore del Faust-nella sua visita a Loreto del 1740. Scrive:
" in simile posizione [=ginocchioni] una cinquantina di uomini E di donne, vecchi e giovani, trottano intorno incontrandosi, dicendo la corona e le loro preghiere ".
Illustre viaggiatore, però, sottolinea un curioso costume connesso con questo gesto penitenziale: i fanciulli di Loreto si prestavano volentieri, dietro pagamento, a percorrere in ginocchio i famosi soggetti al posto dei pellegrini. Narra Johann Gaspar:
" Venne da me un fanciullo povero, offrendosi di fare in mio nome il giro intorno alla Santa casa in ginocchio, per qualche carità, e tante volte che volevo. Fummo d'accordo, ma non fidandomi della sua onestà, lo seguii e ed ecco, mentre si voltò di canto e credendomi fuori dalla vista, si drizzò in piedi, volendo così continuare la via con miglior agio: lo chiamai gridando di ricordarsi del nostro patto, e subito si gittó per terra, poi replicò ancora alcune volte il giro, e alla fine... Fu ricompensato ".
Insomma i Loretanianche i più giovani, avevano un felice intuito nel soddisfare le esigenze del pellegrino, anche le più intime, purché ne potessero trarre qualche profitto!
È da dire anche, però, che i giovanetti di Loreto avevano la pia abitudine di fare il giro attorno alla Santa casa ogni sera. Vincenzo Murri, in una pubblicazione delle 18 01, trascrisse una " canzonetta spirituale " cantata dai ragazzi di Loreto " durante il giro che si faceva tutte le sere intorno alla Santa casa ". È costituita da 25 strofe, la prima delle quali, intonata dal clero, dice:
Brilla l'amabil Iride,
Maria nostra Regina,
Avanti a cui s'inchina
Il ciel, la terra e il Mar.
Secondo un'altra nota d'archivio, Clemente XVIII, il 1 ottobre del 1766 concesse lindo urgenza di sette anni e sette quarantene " a chi girava in ginocchio, nella parte esterna, intorno alla Santa casa "
I pellegrini compivano in genere questo pio esercizio per due ragioni: o per esprimere la propria riconoscenza alla vergine Lauretana in seguito a una grazia implorata e ottenuta, oppure per intercedere da lei una speciale protezione in casi di difficoltà fisiche o morali.
Si leggono anche grazie ricevute durante lo svolgimento di questo atto penitenziale. Un anziano sanmarinese assicurava, non molti anni fa , Di essere stato liberato immediatamente da una grossa ernia al termine del terzo giro.
Certo è che quelli sui pacchetti paralleli, " a guisa di binario d'una ferrovia " -direbbe lo Stoppani- stanno a testimoniare una tradizione di religiosità popolare singolare e commovente.
La rivista del santuario la vergine di Loreto, nel 18 95, scriveva:
" Chiunque è stato Loreto conosci quei succhi profondi scavati nel gradino di duro marmo che circonda l'esterno della Santa casa, sono dessi prodotti appunto dai pellegrini che camminano attorno al sacro abitacolo in quella guisa. Tanto può in quelle anime serventi la venerazione per questo santuario dei santuari e l'amore verso quella santa famiglia che ha santificato di sua presenza".
Il bacio dei fregi e delle immagini
Il Pisani-Dossi osservava nel 1895 che i " regnicoli ", facendo il giro con le ginocchia intorno al rivestimento della Santa casa, "baciavano i fregi e le figure dell'ornamento in marmo che la decorano".
Non solo i "regnicoli", però, bensì moltissimi altri pellegrini, nel loro giro attorno al sacello, con i baci e con lo strofinino delle mani, hanno finito per consumare alcune ornamentazioni del monumento marmoreo.
I baci erano e sono rivolti soprattutto alle immagini sacre scolpite sulle porte di bronzo della Santa casa. Ad alcune di esse si attribuivano addirittura poteri prodigiosi, come annota ancora il Pisani-Dossi.
Fra tutte era oggetto privilegiato di ripetuti baci la figura scolpita nella porta dell'angolo nord-est, rappresentante Cristo flagellato alla colonna, il cui volto è stato letteralmente mangiato dai baci.
Lo stesso fenomeno si riscontra per l'immagine della Vergine, in ginocchio, nella scena dell'annunciazione, raffigurata nella porta ovest del lato sud.
Rievoca il devoto gesto anche il Rotelli con questi ben " costrutti " endecasillabi:
Toccano lievi gli scolpiti muri
Di alati fregi e palpitanti state
E nel sacrario baciano le pietre.
La calca in Santa Casa
I fedeli consideravano e considerano la Santa casa la meta vera del loro pellegrinaggio. Nelle maggiori solennità vi si accalcano in modo tumultuoso e di compiono gesti devoti.
Soprattutto nelle festività primaverili, estive e autunnali i pellegrini affollavano e affollano il piccolo vano della Santa casa. Da tempi remoti il flusso viene regolato dai custodi della stessa. Il tortellini, dopo aver ricordato un concorso eccezionale di 200.000 pellegrini nei giorni 7e 8 settembre, forse delle 1594, annota che i custodi furono costretti, in quell'occasione, a circondare la Santa casa, nella parte interna, con appositi cancelli, al fine di controllare il flusso ed evitare " il tumulto ".
Nel secolo scorso, dopo l'annessione delle Marche al regno d'Italia, stando a un gustoso racconto dello Stoppani, nei giorni di grande concorso, venivano incaricati a regolare il flusso anche due soldati piemontesi, posti l'uno sulla porta di ingresso e l'altro su quella di uscita.
Lo Stoppani assistette alla stiparsi dei pellegrini in Santa casa L8 settembre 18 65, giorno che tradizionalmente registra un grande concorso di popolo. Scrive:
" Quando fui alla porticina d'ingresso di quella devota stanza, la vidi occupata da una folla di pellegrini così stivata, così tutta d'un pezzo, che ce n' era ben due volte quella capacità. Una folla molto maggiore si teneva stretta davanti alla porticina, a guisa di quegli sciami d'api, che si vengono prendere appiccicati dalla bocca dell'alveare quando attendono, per emigrare, il cenno della giovine regina "
L'autore descrive l'imbarazzo di uno dei due soldati piemontesi, nel momento delle ricambio dei pellegrini, momento che solo chi è esperto sa pilotare a dovere. Ecco la piacevole descrizione dello Stoppani, che è anche una bella pagina di costume, la quale, oltretutto, evidenzia la poca comunicabilità tra piemontesi e romani:
" Eravamo al momento in cui i pellegrini dovevano darsi lo scambio. Io credo che quel bravo piemontese si trovasse in peggior impiccio qui, che alla battaglia di San Martino o della Madonna della scoperta a cui al certo era stato presente. Egli intimò a quei di dentro di uscire per lasciar luogo a quei di fuori. Ma Si! ... Aspetta un poco... La calca rimane immobile, come nulla fosse. Il soldato alza la voce; minaccia; ma inutilmente. Quei romani, dalla voce sonora e 100 unità, si credevano certamente dispensati dall'intendere l'arabo o il cinese del loro fratello subalpino. Bisogno venire alle vie di fatto; e qualche spintone colla mano, qualche urto, peraltro moderatissimo, col calcio del fucile, valsero meglio delle parole. Quella folla immobile cominciò ad agitarsi, a formicolare, a realizzarsi, avvolgersi verso l'uscita, finché lentamente la santa cella rimase sgombra.
Qui sta il Busillis pel povero soldato! Come aprire il cancello che difendeva l'ingresso, sotto l'incubo un'altra folla che strapiomba, che minaccia di rovinare tutta d'un pezzo entro la cella, seppellendo, se fa d'uopo, il povero guardiano?
-Indietro!Adagio!C'è tempo!-esclamava il poveraccio.-Così non potete entrare!...
Ma si! Insegnare la logica alla folla...Infine, non so come, il cancello s'apri. Io vidi come un vortice di teste, ti spalle, di braccia, di gambe, una specie di torrente umano, ti rovinava attraverso la porticina. La sentinella era tutta sudata, trafelata… Ma era salva!"
Altre testimonianze illustri sottolineano la calca in Santa casa e le espressioni di devozione dei fedeli, non sempre controllate. Ne spigoliamo una fra tante, quella di Josemaria Escrivá de Belanguer, il noto fondatore dell'opus dei, sacerdote di alto spicco, molto devoto della Madonna.
Fu a Loreto il 15 agosto 1951 e ottenne di celebrare in Santa casa, nonostante la festività dell'assunta. Scrive:
"Non avevo pensato che un giorno di festa così solenne avrebbe richiamato dai dintorni un gran numero di persone che portavano con se la fede benedetta di quella terra che tanto amore alla Madonna. La loro pietà li spingeva a manifestazioni non del tutto appropriate, se si considerano le cose-come dire?-Soltanto dal punto di vista delle leggi irrituali della Chiesa. Infatti, quando baciavo l'altare, secondo le prescrizioni del messale, tre o quattro donne lo baciavano con me. Ero distratto ma commosso ".
Non occorre neppure osservare che l'angustia della Santa casa e la vivissima devozione che essa suscita nei fedeli sono la causa di questo fenomeno della calca, abituale e inevitabile ieri come oggi.
Il toccamento e il bacio delle "sante pietre"
È il gesto dei pellegrini, il più semplice, più spontaneo e- se si vuole -il più scontato, ma pur sempre toccante, perché suggerito da una sincera devozione verso i muri-reliquia del sacello nazaretano.
L'uso risale a tempi remoti e non definibili. Si trova registrato in testimonianze degli inizi del secolo XVI.Jacques La Saige , Pellegrino a Loreto nei giorni 9-12 maggio 1518, ha lasciato scritto:
"io credo che il Benedetto Gesù, quando imparò a camminare, si appoggiava al muro della detta casa. Noi vi abbiamo toccato nel frattempo le nostre corone di Rosario ".
Il poeta LorenzoFrizolio, nel 1578, in una sua ode latina, preso da empito lirico e mistico a un tempo, immaginandosi dentro la Santa casa E ripensando agli eventi salvifici ivi compiuti sì, esclama:
Quali baci imprimer ho sulle pietre,
E su quali pietre?
Ma il rito era frequente. Lo attesta il solito Torsellini, che nelle 15 97 scriveva:
" Tutti fissano attentamente l'altare degli apostoli, il benedetto armadio, la porta chiusa e il benedetto camino. E mentre vanno ripensando a qualche azione che compì la beatissima vergine in quei posti, non vorrebbero porre fine a guardare e a baciare, se l'ardore di moltissimi, che hanno lo stesso desiderio, non lo impedisse loro".
Anche San Francesco di Sales S, nel suo pellegrinaggio a Loreto delle 15 99 esprime una simile venerazione verso le mura della Santa casa, come scrive il suo nipote Charles-Auguste de Sales:
"Umilmente prosterna nato in ginocchio, e gli bacia questa terra Santa e queste sacre mura ".
L'uso di baciare e toccare le pietre e vivo ancora oggi. Scrive Chiara Lubich-la quale il 18 maggio 1939 ebbe in Santa casa l'ispirazione ad avvita al movimento dei focolari-che in quell'occasione " con venerazione toccava quelle pietre e quelle assi ".
Uno sguardo, anche se superficiale, alle pietre della Santa casa rivela il continuo ripetersi di un simile rito: esse sono consumate, non solo dallo finirono delle mani, ma anche dai baci. Qualcuno dei singolari graffiti incisi sulle " Sante pietre ", giudicati dagli esperti di origine giudeo-cristiana, stanno a testimoniare, nella loro lucida convinzione, la serie infinita dei baci impressi dai devoti.
Asportazione di pietre e frammenti
Un altro costume, diffuso soprattutto nel passato, era quello di asportare pietre o frammenti di calce, nonostante il severi divieti e crisi astici, che prevedevano in simili casi perfino la scomunica.
Il Torsellini riferisce una copiosa serie di episodi in proposito. Nelle 1561 il portoghese Giovanni Suarez, vescovo di Coimbra, mentre era al concilio di Trento, ottenne da Pio IV l'autorizzazione di asportare una pietra della Santa casa per collocarla in una chiesa della sua diocesi, edificata sul modello della sacello lauretano. Diede l'incarico per l'operazione al sacerdote aretino Francesco stella, il quale, dopo l'esecuzione del mandato, subì vari incidenti nel suo viaggio verso Trento. Il vescovo fu poi assalito da terribile febbre e, dietro consiglio di una monaca rispedì la pietra al Loreto, la quale oggi si scorge a destra dell'altare della Santa casa, incapsulata in una/di ferro. Nella credenza, a sinistra dello stesso altare, si conserva copia della lettera che attesta il fatto.
Un episodio simile si narra di un vescovo tedesco, che, nel 15 57, avendo accettato una pietra asportata dalla Santa casa da un suo connazionale, forse un soldato, per collocarla in una chiesa o cappella dai ficcare, cadde gravemente ammalato e guarì solo dopo aver restituito la reliquia al santuario loretano. La pietra ora si osserva nella parete nord della Santa casa, circoscritta da segmento metallico.
Non solo i vescovi, ma anche i semplici pellegrini amavano provvedersi di reliquie delle sacre mura. Nelle 1559 un signore restituì al santuario una pietra rubata molti anni prima, dopo aver perduto figli e beni ed essersi seriamente ammalato.
Una donna marchigiana. Via una pietra, convinta di poter vincere così la propria sterilità, ma assentitasi inspiegabilmente male, su consiglio di un sacerdote, la restituiti al santuario.
Alcuni pellegrini " Schiavoni " presero furtivamente una pietra e la nascosero nella loro nave tra il grano acquistato nelle Marche, ma una tempesta Convolgente li costrinse a riportare la reliquia a Loreto.
Nel 1585 fu restituita solennemente al santuario una pietra che 20 anni prima un palermitano aveva sottratto in Santa casa. Fu presa in consegna dallo stesso governatore di Loreto che la riportò nel sacello, dove i presenti notarono con stupore il rispettivo luogo sul muro, arrestato vuoto.
Il Torsellini riferisce anche episodi di pellegrini che asportarono dalla Santa cappella " pezzetti di calce ", costretti poi a restituirli per il sopraggiungere di strani malori. Era accaduto, ad esempio, ad una persona di Alessandria e a due sacerdoti.
Lo storico annota: " vari esempi ritrovo di molti, i quali, avendo tentato la stessa cosa, ben presto riportarono il dovuto castigo della loro temerità, fino a quando, arresi e tutti dal male, restituivano quello che avevano tolto ".
Proprio nello scorcio di un tempo in cui scrive il Torsellini (1597), Tra la fine delle 500 e gli inizi del seicento, le alterità del santuario elaborare un progetto-inattuato-per proteggere le mura della Santa casa con pannelli di bronzo intercalati da spazi vuoti che consentivano di intravedere le pietre. Il progetto, per quanto artisticamente immaginato, aveva carattere essenzialmente funzionale, perché tendeva appunto a difendere l'integrità fisica del sacello. Lo lasciava intendere chiaramente la scritta che illustra quell'ipotesi progettuale: " questi cancelli eviteranno molte scomuniche papali et altri sacrilegi, nelle quali cascano ogni anno tanti che li robano et con la loro stolta et impia rivoluzione violalo questo tremendo loco ".
I penitenziere sapevano bene " come spesso molti per la loro temerarietà et stolta divozione restano bene spesso molto bene flagellati, o per sempre, o fintanto che riprendono le sacre reliquie, le quali anche quando sono rese non si possono restituire nelle loro propri luoghi ed così sì perdono".
Il costume si è protratto per secoli, fino ai giorni nostri. Nella vita di San Gabriele dell'Addolorata si legge che egli, nel suo pellegrinaggio a Loreto del sette-8 settembre 1856, usò portar via dalla Santa casa un calcinacci, staccandolo di propria mano, e che il custode lo costrinse a restituirlo.
Anche Santa Teresa del Bambin Gesù, pellegrina Loreto il 13 novembre 1887, ebbe la tentazione di " grattare furtivamente i muri santificati della presenza divina ".
In tempi recenti, P. Arsenio d'Ascoli riferisce che un uomo gli consegnò un pezzo di cemento, dicendogli: " è un anno che non ho pace. La madonna mia punito. Punto. Lo riporti alla Madonna, padre ". Talvolta perviene al santuario qualche plico con dentro un frammento di calcinaccio O di pietra della Santa casa e uno scritto che spiega come esso sia stato asportato e poi restituito per disagi sopravvenuti. I custodi della Santa casa segnarono spesso tentativi di pellegrini diretti all'asportazione di parti di pietre o di cemento della Santa casa.
Talvolta i pellegrini, pentiti, si presentavano-o si presentano-agli stessi custodi riconsegni premiando le piccole reliquie sottratte. I custodi prendono i frammenti e ricollocano vicino alla scodella detta di Gesù per reinserirmi poi nelle pareti, quando vi si aggiunge un nuovo cemento per suturare i piccoli fori procurati dei pellegrini che con chiodi o temperini tentano di appropriarsi, appunto, di qualche briciola del devoto sacello.
senza voler escludere a priori la veridicità di quanto la documentazione riferisce sui malanni occorsi ai trafugatori di pietre e di frammenti della Santa casa, sembrerebbe di cogliervi, però, la legittima preoccupazione delle autorità per l'integrità edilizia del piccolo sacello, da rispettare a ogni costo, pena la sua definitiva dispersione.
I mali avvertiti dai trafugatori, oltre che come segni ammonitori dall'alto, possono essere spiegati anche con il disagio psicologico di chi, sacrilegamente, allunga la mano su una cosa santa e contravviene precise disposizioni.
Comunque sia, il fenomeno si iscrive nel costume dei pellegrini antichi e contemporanei. Per restare nell'ambito della Santa casa, si può notare che episodi analoghi si verificano a Nazareth.
Giacomo da Verona ad esempio, pellegrino a Nazaret nel 1335, informa: " nella grotta della vergine si trova un altare e vicino un'altra piccola Volta, dove stava la vergine Maria a pregare e dalla roccia di quel luogo io ho preso qualcosa ". Riferisce anche che non poté asportare nulla da una colonna, ivi posta, " perché la pietra è durissima ".
Lo osservava nel 1347 anche Nicolò da Poggibonsi con queste parole: " La colonna si è di color bigio; sappi che ella è durissima, che niente se ne puote avere ".
Ottavio via Asmara, in uno scritto del primo trentennio del secolo 16º, annota che tra le reliquie della propria area, Margherita giullari, si conservava " una particella del cemento delle fondamenta Nazaretane" della Santa casa, cemento ritenuto da lui identico a quello delle mura del sacello lo Reitano.
Si tratta, dunque, di un costume antico e diffuso, che al Loreto registra manifestazioni più frequenti e, se si vuole, più significative.
La "credenza della Madonna" e le "sante scodelle"
Nella parete sud della Santa casa esiste un piccolo vano, all'atto dell'altare, dove ora si collocano le ampolline. L'immaginazione popolare lo identificava nel passato con la " credenza ", dove la Madonna avrebbe riposto le vivande e le stoviglie domestiche.
Già nel 1518 Jacques La Saige osservava che un canonico mostrò all'lui e ad altri pellegrini il luogo " dove la vergine Maria riponeva la carne ".
Il Bartoli nel 16 86 parlava anche del " Santo armadio ", annotando:
Vendesi situato nella muraglia al lato destro dell'altare con porta di argento Donata dalle duca di Parma. In esso, per tradizione de' santi dottori, si vuole che la beatissima vergine per essere custodita la sua Bibbia, e di poi se ne fossero serviti gli apostoli per tabernacolo da riporre il divino sacramento.Hora[...] in esso si conservano i sacri vasi ".
L'autore descrive anche il " santo cammino ", ricavato nella parete orientale e, quindi, sicuramente spurio. Annota:
" E vi il santo canino, in cui è probabile ( conforme asseriscono gli storici, particolarmente bello denota il Briganti) Che la beatissima vergine fosse solita far fuoco, preparare le povere vivande, e servirsene per altre occorrenze e bisogni ".
Pellegrini osservavano con ammirazione tutte queste parti della Santa casa, compreso l'altare degli apostoli, i quali, secondo una fantasiosa versione, lo avrebbero eretto a Nazaret e vi avrebbero celebrato.
Un altro minuscolo vano, sulla parete sud, a sinistra della porta di entrata, accoglie un'antica acquasantiera, dalle rudi forme. Fino agli sia in questo secolo vi si conservava l'acqua santa, ma il pellegrini, per devozione, non solo la asportavano, ma vi si lavavano le mani e viso e la bevevano perfino. Per ragioni igieniche allora le autorità del Santuario disposero che non vi si collocasse più acqua benedetta.
Forse a questa acquasantiera si riferiva Jacques La Saige , Quando nelle 15 18 scriveva che un canonico dimostrò " un piccolo lavabo "-simile a quelli usati nelle chiese dei sacerdoti-nel quale " la bella signora lavava le sue mani ".
Nell'armadio collocato a lato sinistro dell'altare, chiuso da una griglia metallica, si conservano ora due pazze giudicate di matrice Monza arabica.
Secondo del relazioni, i pellegrini pensavano che " se ne servisse la vergine mentre mangiava con il Gesù e San Giuseppe ".
Per questa via convinzione dei fedeli, si era dato vita a un curioso costume. Assicura Tommaso barbaro, nel 17 39: " queste scodelle Siri Piero d'acqua, colla quale si stempera la farina e si fa il pane benedetto che si distribuisce per devozione al Pellegrini ".
La scodella che riscuoteva maggior devozione era, però, quella ditta di Gesù bambino. Prima dell'incendio, scoppiato in Santa casa nel 19 21, veniva custodita in un cestello d'oro, finemente lavorato, attribuito addirittura a benvenuto Cellini o alla sua scuola. L'incendio fuse l'involucro di metallo prezioso e incrinò in più parti la scodella, la quale, dopo un primo rabberciamento, fu restaurata nel 19 64 a cura della soprintendenza alle antichità di Ancona.
Il civili nelle 19 22 provvidi a sostituire il cestello attribuito alle Cellini con altra custodia di argento brunito, approntando disegnii raffiguranti l'annunciazione e Natale di Gesù.
La scodella di terracotta invisa, con diametro alla bocca di centimetri 17,6, recante tracce di interlineatura, viene assegnata dagli studiosi al primo secolo avanti Cristo o al primo secolo dopo Cristo. Il Nogara afferma che sia addirittura del periodo erodiano imperiale. Ora la scodella si conserva-chiusa-nell'angolo destro del santo cammino.
Il Bartoli, nelle 16 86, al riguardo di questa scodella, scriveva: " si mostra ogni sera, sulle 22 ore, fedeli, nella detta scodella si toccano per devozione le medaglie, corone, croci e cose simili, e se sperimenta che, bevendo con la fede acquasanta passata per essa, se ne riceve giovamento e salute".
Il Murri aggiunge che " esitava a baciare ai devoti ".
Anche Santa Teresa di Lisieux , Nel suo pellegrinaggio a Loreto del 13 novembre 18 87, ripeté questa deduzione: " ho deposto-scrive-la mia corona del rosario nella con la scodella di Gesù bambino ".
Stando a una relazione redatta il 25 luglio 16 04, durante i lavori della ristrutturazione del soffitto della Santa casa e della messa in opera delle relativo rivestimento marmoreo 15 34 C., Furono ritrovati " sul muro alquanto vacuo murati diversi vasi, piatti, scodelle e catini". Uno, restituito da un muratore di porto Recanati, che aveva partecipato quei lavori, presi in consegna dai padri gesuiti del palazzo illirico di Loreto. In esso gli infermi bevevano l'acqua con devozione riportandone " il giovamento ".
C'è chi pensa che questa sorella barra identificata con quella ditta di Gesù bambino e che, quindi, la devozione verso di essa risalga ai primi anni del secolo 18º.


